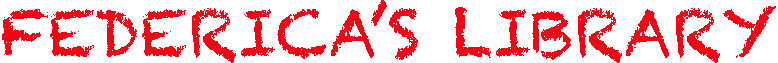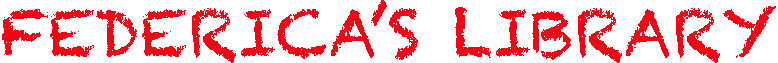|
Un altro giro di giostradi Tiziano Terzani
CURA non è GUARIGIONE
La malattia non è una condizione naturale dell'uomo.
L'uomo, se è determinato, può fermare una tigre e mungerla.
Recitare un mantra ha un effetto sullo spirito e la mente perché:
1) regolarizza e calma il respiro
2) dovendo pensare prima di tutto alle parole da dire, la mente guarda con più distacco qualsiasi altro pensiero.
[Dieter ed io] c'eravamo conosciuti in Indocina durante la guerra e lui molto prima di me aveva deciso di mettersi in cerca del senso della vita a costo di accorciarsela.
SPIRITUS LOCI
Teatro di vita...
Forse, a vivere da soli si perde il senso della misura.
La vita è un'occasione per conoscere se stessi.
"La terra ha abbastanza per il bisogno di tutti, non per l'ingordigia di tutti." Gandhi
Tutte le malattie sono curabili, ma non tutti i pazienti.
"Ci sono mille modi di inginocchiarsi e di baciare la terra", scrive il più grande dei poeti sufi Gialal al-Din Rumi, nato in quel che è oggi l'Afghanistan nel 1207. "Di là dalle idee, di là da ciò che è giusto e ingiusto, c'è un luogo. Incontriamoci là."
Un vecchio monaco sta per morire. Si mette a letto e annuncia che entro la sera se ne andrà. Tutti i suoi discepoli accorrono al suo capezzale. Solo uno, il più devoto, invece che andare dal mestro corre al mercato. Cerca un dolce che sa piacere moltissimo al monaco. Il dolce non c'è e il novizio impiega una intera giornata per farne fare uno. Di corsa, sperando di arrivare ancora in tempo, torna alla cella del maestro. Appena si affaccia alla porta, quello apre gli occhi e dice: "Finalmente! E il doce dov'è?" Ne prende un pezzetto e si mette a mangiarlo con grande gusto.
I discepoli sono esterefatti. Uno chiede: "Maestro, qual è il tuo ultimo insegnamento? Dicci qualcosa con cui ti potremo ricordare."
Il maestro sorride. "Questo dolce è squisito", dice lento, soppesando le parole.
La sua ultima lezione è semplice: vivete ora, vivete nel momento. Il futuro non esiste. Siate coscienti. Ora, in questo momento, questo dolce è delizioso. Persino la morte non conta... ancora.
Col passare degli anni avevo cominciato a capire che i fatti non sono mai tutta la verità e che al di là dei fatti c'è ancora qualcosa come un altro livello di realtà - che sentivo di non afferrare e che comunque sapevo non interessare il giornalismo, specie per come viene ormai praticato.
Nella vecchia Cina molti tenevano in casa la loro bara per ricordarsi della propria mortalità; alcuni ci si mettevano dentro quando dovevano prendere decisioni importanti, come per avere una migliore prospettiva sulla transitorietà del tutto.
Più stavo con la scienza e la ragione, più mi cresceva dentro la curiosità per la magia e la follia delle "alternative" che avevo scartato all'inizio. Non certo perché credessi di aver sbagliato strada (è la prima che suggerirei a tutti di prendere in considerazione), ma perché sentivo che quella strada, pur essendo probabilmente la migliore, aveva i suoi limiti e che altrove, percorrendo altre vie, potevo trovare qualcos'altro: non certo qualcosa di "alternativo", ma forse qualcosa di complementare.
I miracoli? Certo che esistono, ma sono convinto che ognuno deve essere l'artefice del proprio.
Basta ammalarsi, e il corpo diventa il centro di tutta la nostra attenzione; il semplice respirare, orinare e "l'andar di corpo", come dicevano i vecchi, diventano fatti essenziali che determinano gioia o dolore, che fanno sorgere sollievo o angoscia.
Le leggi sono inadeguate e la caotica, indiscriminata valanga di informazioni prodotta di internet ha creato quell'ormai diffusissimo sapere a metà che è la peggiore e la più pericolosa forma di ignoranza.
...come se la vita fosse un eterno banchetto romano in cui si mangia e si vomita per poter rimangiare.
Viaggiare. Il piacere di una vita. Un desiderio d'adolescente diventato in mestiere, un modo di essere. Sempre lo stesso, eppure sempre diverso: prepararsi a partire, andare, scriverne. Ma il senso di tutto questo? Sinceramente, non m'ero mai fermato a chiedermelo.
Ora, seduto sulla terrazza del Ganges View Hotel a Benares, a guardare l'eterno scorrere del fiume più sacro del mondo e quello, qui ugualmente ineffabile, dell'umanità più antica, quel senso m'era chiaro. La ragione di tutto quel muovermi, di quell'andare continuamente fuori in cerca di qualcosa era semplice: io non avevo niente dentro di me. Ero vuoto. Vuoto come è vuota una spugna, pronta però di riempirsi di quello in cui è tuffata. La metti nell'acqua e d'acqua s'imbeve, la inzuppi nell'aceto e diventa acida. Non avessi viaggiato non avrei mai mai avuto niente da dire, da raccontare; niente su cui riflettere.
"Tutto sta nel liberare la mente dalla schiavitù delle verità scientifiche che la condizionano", spiegò Ramananda.
Il potere non sta nella cosa in sé, ma nel potere della mente che crede nel potere della cosa. I tibetani lo spiegano con questa storia.
Un monaco, dopo anni di assenza, decide di andare a trovare la madre che sa poverissima e che immagina sul punto di morire di fame. Ma al villaggio lo aspetta una sorpresa: la madre sta benissimo. Un vecchio sadhu le ha dato un mantra grazie al quale lei mette dei sassi in una pentola e quelli, al suono del mantra, diventano patate. Quando la madre con quel suo sistema si mette a preparare la cena, il monaco, ormai espertissimo di cose sacre, si accorge che lei pronuncia male le parole sanscrite del mantra e la corregge. La madre, orgogliosa del sapere del figlio, intona subito la nuova versione, ma il risultato è deludente. I sassi nella pentola restano sassi e i due non hanno nulla da mangiare. Il monaco capisce, prega la madre di tornare alla sua versione del mantra e, miracolosamente, nella pentola compaiono delle fumanti patate.
Né mia madre né mia nonna, che viveva con noi quand'ero ragazzo, conoscevano i mantra, ma anche loro recitavano preghiere e cantavano inni che, se anche non trasformano i sassi in patate e ce ne sarebbe stato bisogno! - contribuivano però al ritmo delle loro giornate. Così era quand'ero ragazzo: i contadini cantavano nei campi, gli artigiani lavorando nelle loro botteghe e noi cantavamo a scuola. Se penso ai suoni che hanno accompagnato la mia infanzia le campane ad esempio e quelli di cui deve invece alimentarsi oggi mio nipote, mi viene da disperarmi.
Abbiamo smesso di cantare per ascoltare tutt'al più, son un sistema hi-fi, altri che cantano. E questo non è sano. Se ne accorsero negli anni Sessanta i benedettini di un monastero francese quando vennero tutti colpiti da una strana malattia. Improvvisamente cominciarono a sentirsi stanchi, depressi e distratti. Si riunirono e decisero di dormire di più. Ma questo peggiorò la situazione: erano più stanchi e più depressi che mai. Consultarono allora dei medici. Uno suggerì loro di mangiare della carne, cosa che non facevano da duecento anni. Nessun miglioramento. Infine un bravo medico di Parigi scoprì che in seguito alle nuove regole introdotte da Concilio Vaticano Secondo, un intraprendente aveva ridotto notevolmente le ore di canto per aumentare quelle dedicate alle attività produttive. Questo aveva cambiato la routine del convento, disse il medico e come terapia suggerì semplicemente di ritornare alle abitudini di prima.
Dopo qualche mese i monaci erano di nuovo in ottima salute e di buon umore. Il canto sintonizzava la loro respirazione e quella sintonia induceva in loro un aumento di energia e di vitalità. Le alte frequenze prodotte dal cantare ricaricavano la corteccia cervicale, creando uno stato di euforia che permetteva ai monaci di sentirsi beati di giorno e di notte.
Qualcosa di simile succedeva a noi nell'ashram. Persino a me che ero stonato.
"Stupendo, non le pare?", esultò Mahadevan. "La salute non sta nella normalità delle varie analisi che fa la medicina occidentale: TAC normale, esame del sangue normale, colesterolo normale. Una persona può avere tutti questo normale e non stare affatto bene. E questo è particolarmente vero quando la mente è instabile. Swasta significa armonia, stabilità nella realizzazione del Sé. Questa per noi è la vera salute."
E da piccolo, mia nonna, non mi obbligava a fare pipì subito dopo che mi ero preso per qualche ragione un gran spavento? Era ovviamente un vecchio modo di eliminare dal sistema i residui negativi di un'emozione che si pensava potesse avere brutte conseguenze. Lo raccontai a Mahadevan e lui mi disse che in India si fa esattamente la stessa cosa. Anche con gli adulti. Se una persona a cui è morto qualcuno di caro non piange, i familiari ricorrono alle cipolle, al fumo negli occhi e se ancora non piange, arrivano addirittura a picchiarla pur di farle sciogliere quel nodo di emozioni.
Secondo Mahadevan, col giusto modo di mangiare lo stomaco deve riempirsi solo per metà di cibi solidi, per un quarto di liquidi e per un quarto d'aria.
Ogni malattia è frutto della nostra vita, è la nostra malattia, ed è assurdo non rendersene conto e pensare, come fa la scienza, che basta prendere delle medicine perché quelle mettano obbiettivamente fine a tutti i nostri mali.
L'umanità forse non saprà neppure che i Teduray sono mai esistiti, ma in qualche modo pagherà per la loro scomparsa, perché se la biodiversità è necessaria alla vita della terra, la diversità culturale è indispensabile alla salute psichica dell'uomo.
Questo è davvero qualcosa su cui in Occidente dovremmo riflettere di più. Il nostro concetto di morte è sbagliato. Leghiamo troppo la morte alla paura, al dolore, alla tenebra, al nero: esattamente il contrario di quello che succede nella natura in cui il sole muore ogni giorno in una gioiosa esplosione di luci, in cui le piante d'autunno muoiono al meglio di sé, con una grandiosa esuberanza di colori. Dovremmo forse dirci, alla maniera dei Teduray, che moriamo solo quando abbiamo deciso noi, o dovremmo, alla maniera dei tibetani, considerare la morte non come il contrario della vita, ma semplicemente come l'altra faccia della nascita, come una porta che, vista da una parte, è l'ingresso, dall'altra è l'uscita.
"E questa non è la sola coscienza." Toccandosi il petto concluse: "Ciò che è fuori è anche dentro; e ciò che non è dentro non è da nessuna parte."
Dovevo trovare in me il seme di una pace che poi avrei potuto far germogliare ovunque.
Mi rendevo conto che questo dipendere dalla solitudine per essere in pace era una forma di immaturità.
Un volta chiesi al Vecchio se la famiglia poteva essere un ostacolo alla vita interiore.
"Per Buddha lo fu", rispose. Poi, quando capì che parlavo di me e che il paragone con l'Illuminato non calzava, mi raccontò una storia di Tagore intitolata "L'aspirante asceta". "Questa fa più al tuo caso", disse.
Un uomo decide di lasciare la famiglia per farsi sanyasin. Una notte quando, di nascosto, sta per partire, getta un ultimo sguardo alla moglie e ai figli addormentati e, rivolto a loro, dice: "Chi siete voi per tenermi qui incatenato?"
Una voce nel buio bisbiglia: "Loro sono me, sono Dio."
L'uomo non fa attenzione. Non ascolta e parte. E a Dio non resta che concludere: "Ecco uno che, per cercami, mi abbandona."
No. Alla lunga io non ero fatto per l'ascetismo, per la rinuncia. La vita era per me ancora qualcosa di meraviglioso, un richiamo forte. Il mio stesso sentirmi così bene nella natura ne era una riprova. Un giorno mi colì vedere come alcuni fiorellini crescevano, commoventi, nelle fessure fra le pietre della mia casa. Tenaci e fantasiosi. Quella loro determinazione di vivere godendo del sole era anche la mia.
Trovavo che era molto più nel mio carattere includere che escludere come invece avevo fatto di recente. Al limite trovavo l'includere anche più saggio.
Alla fine tutto va messo alla prova: le idee, i propositi, quel che si crede di aver capito e i progressi che si pensa di aver fatto. E il banco di questa prova è uno solo: la propria vita. A che serve essere stati seduti sui talloni per ore e ore a meditare se non si è con questo diventati migliori, un po' più distaccati dalle cose del mondo, dai desideri dei sensi, dai bisogni del corpo? A che vale predicare la non violenza se si continua a profittare del violento sistema dell'economia di mercato? A che serve aver riflettuto sulla vita e sulla morte se poi, dinanzi a una situazione drammatica, non si fa quel che si è detto tante volte bisognerebbe fare e si finisce invece per ricadere nel vecchio, condizionato modo di reagire?
Tutta l'esperienza che avevo accumulato negli ultimi anni sulla strada e poi nel mio rifugio nell'Himalaya, tutto quel che avevo pensato o intuito veniva ora a un nodo. Questa era la grande sfida a cui mi ero preparato. Il resto era letteratura.
Un giorno una madre portò suo figlio [dal Mahatma Gandhi]. Aveva quindici anni e il medico gli aveva ordinato di non magiare più zucchero altrimenti la sua vita sarebbe stata in pericolo. Il ragazzo non sentiva ragione, continuava a rimpinzarsi di dolciumi e la madre sperava che Gandhi lo potesse aiutare. Gandhi ascoltò, poi disse: "Ora non posso farci niente. Tornate fra una settimana."
Quando tornarono, Gandhi prese il ragazzo da parte e gli parlò. Da allora il ragazzo non toccò più niente di dolce. "Gandhi-ji, come hai fatto?", gli chiesero i suoi seguaci. "Semplice", rispose la Grande Anima." Per una settimana io stesso non ho toccato zucchero e così, quando ho parlato a quel ragazzo sapevo cosa voleva dire non mangiarlo e sono stato convincente."
| |